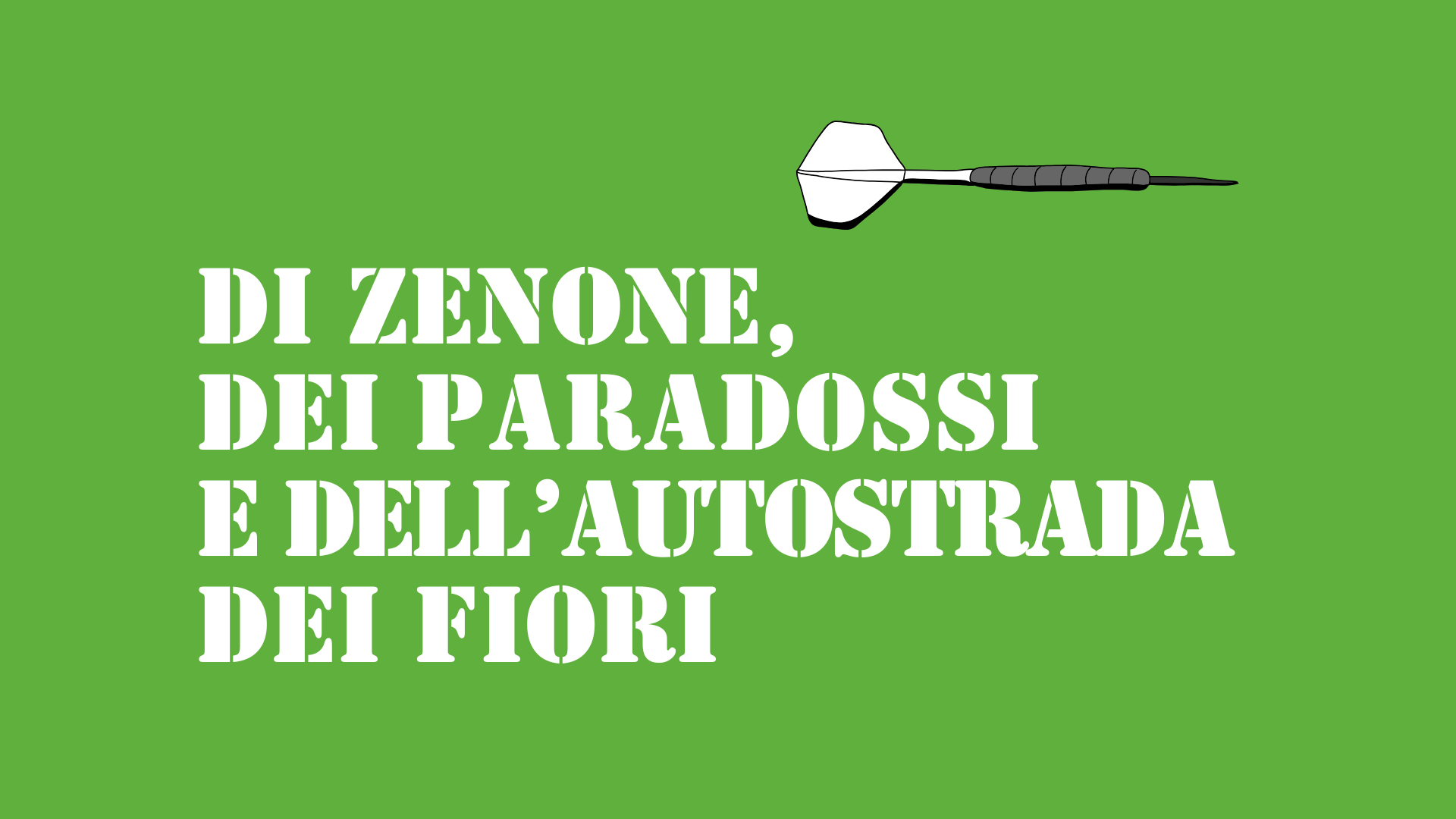Di Sonia Cosco

Voi pensate di aver appena iniziato a leggere un filosketch sulla rivista Arghía e sempre con implicita fiducia, pensate di finire di leggerlo entro un paio di minuti. Illusi! Esclamerebbe il filosofo Zenone di Elea. Quanta ingenuità. Come quelli che pensano di partire da Savona, immettendosi nella A10 in direzione Genova e di raggiungere il capoluogo. A questo proposito, valutando le condizioni disastrose in cui versa la viabilità ligure (che sia su strada che sia su binari) tra rallentamenti, ritardi, eterni lavori in corso, non possiamo che dare ragione al filosofo eleatico vissuto nel V secolo a.C. e quindi forse davvero non arriveremo mai a destinazione.
Però Zenone, non solo sostiene che non arriveremo mai a Genova, ma che non
possiamo neanche partire e che, addirittura, non esiste proprio alcuna possibilità di viaggiare e gli argomenti che usa non hanno a che fare con i disservizi da imputare a Autostrade per l’Italia S.p.A. o Trenitalia, bensì con quelli che lui chiama “paradossi”. Ragionamenti che vanno contro l’opinione comune (“doxa”), che partendo da premesse ritenute evidenti, giungono a conclusioni che vanno contro la stessa opinione comune. Zenone sembra davvero il classico esempio del filosofo che vuole complicare la vita, là dove sarebbe facilissima, uno che trova un problema per ogni soluzione. E i suoi paradossi – che lui aveva elaborato per difendere il suo maestro e amante Parmenide dall’accusa di non capirci nulla con la storia che non esistesse né mutamento né movimento – hanno avuto un grande successo, più nel corso dei millenni che in quel di Elea.
Parmenide, ricordate, aveva attribuito all’essere le caratteristiche di immobilità ed eternità, per cui il mondo era diventato il regno addormentato sotto l’incantesimo di una strega cattiva. Zenone non solo rincara la dose ed evita di dare il bacio del risveglio, ma si fa avvocato difensore dell’uomo di cui era diventato il discepolo prediletto. Pare in effetti fosse bravissimo con le parole (Aristotele lo ritiene non a caso l’inventore della dialettica) e sappiamo che due erano le sue passioni: la filosofia e la politica. Finché non venne catturato, torturato e ucciso per aver cospirato contro un tiranno, passò la sua esistenza a dimostrare che è molto più illogico credere nel movimento e alla molteplicità, piuttosto che il contrario.
“Uditore e amasio di Parmenide”, Platone lo descrive “di figura slanciata, elegante e gradevole a vedersi”. Durante la tortura si mozzò la lingua con un morso e la sputò in faccia al tiranno (ci racconta Clemente Alessandrino), un po’ lo stile rude del pastore del Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Il tiranno allora ordinò che venisse pestato in un mortaio e ridotto in piccoli pezzi. E insomma, a smontare i suoi argomenti contro il mutamento, si intromise la sua stessa morte, perché prima lui c’era e poi come accade al basilico ligure sotto il pestello, non più, ma Zenone, a quel punto, non poteva più ribattere.
Torniamo al nostro viaggio della speranza sulla A10, Savona/Genova. Perché secondo Zenone noi non arriveremo mai a destinazione? Perché prima di raggiungere Genova dobbiamo effettuare metà del tragitto e quindi, più o meno arrivare ad Arenzano, ma per arrivare ad Arenzano dobbiamo raggiungere la metà di questo tragitto (e quindi su per giù Varazze), ma per arrivare a Varazze… insomma avete capito (almeno chi abita in Liguria e conosce i posti), dovendo giungere sempre alla metà della metà della metà della metà (puntini puntini) del tragitto, scopriremo che non solo non potremo arrivare mai a destinazione, ma che non siamo mai partiti! Famoso è il secondo argomento di Achille e la tartaruga. Achille (notoriamente riconosciuto come piè veloce) non raggiungerà mai la tartaruga (notoriamente riconosciuta come molto lenta), se la tartaruga ha un vantaggio. Infatti, prima di raggiungerla, Achille dovrà raggiungere il punto da cui è partita la tartaruga, mentre lei sarà avanzata, quindi la tartaruga avrà sempre un vantaggio.
Cambiamo ora scenario. Immaginiamo di essere appassionati del gioco delle freccette. Qualcuno potrebbe mai negare che quelle freccette si stiano muovendo verso il bersaglio? Non noi, ma Zenone sì. Il ragionamento che fa è il seguente: la freccia in ogni istante occupa uno spazio che è uguale alla sua lunghezza e quindi il movimento che noi vediamo non è altro che la somma di istanti immobili e una somma di istanti immobili non può essere movimento. Tu chiamali se vuoi sofismi, cavilli, però i ragionamenti di Zenone non fanno una piega, se ammettiamo però, come hanno fatto notare diversi matematici e logici, due impliciti: l’infinita divisibilità dello spazio e del tempo e il regresso all’infinito. È come se Zenone ci dicesse: siamo dentro una pellicola cinematografica, siamo solo la somma di fotogrammi immobili e, come avviene per i film in pellicola dell’era analogica, ci muoviamo solo per effetto illusorio di una successione di istanti immobili, proprio come il film è effetto illusorio di una successione di fotogrammi immobili. Zenone mette in crisi movimento, mutamento e quindi spazio e tempo, in quanto divisibili all’infinito, si possono sempre trovare infiniti altri punti nello spazio e tra due istanti nel tempo infiniti altri istanti.
Ma noi non siamo davvero in un film, anche se il cinema, in effetti, con i paradossi soprattutto temporali, si è divertito molto. Penso a Ritorno al Futuro di Zemeckis, in cui il giovane protagonista Marty, che viaggia nel tempo, seduce la ragazza che trent’anni dopo diventerà sua madre, il che però crea il paradosso che se la madre del giovane non conosce suo padre, Marty non può nascere e se non può nascere, non può tornare indietro nel tempo e sedurre la madre. Anche nei film di Nolan da Interstellar a Tenet ci sono veri e propri rompicapi che sono pane per i denti degli appassionati, come nella miniserie retrofuturista Tales from the Loop ambientata in Ohio, dove un acceleratore di particelle causa paradossi temporali e sfasamenti di ogni genere sulle ipnotiche note di Philip Glass che fanno da colonna sonora.
Se c’è il molteplice, questo molteplice è grande e piccolo: grande fino ad essere infinito in grandezza, piccolo fino a non avere grandezza di sorta
oltre che una frase di Zenone, potrebbe essere la didascalia di una delle illusioni prospettiche dell’artista olandese Escher, che infatti nell’opera Sempre più piccolo gioca sulla questione dei limiti della divisibilità dei corpi, come se il disegno fosse inghiottito in uno luogo senza confini.
I paradossi sono sempre stati stimoli a pensare (dal “paradosso del mentitore” che vi invito a cercare, fino al paradosso già citato “del nonno”), sfide per i matematici e i logici che provano a smontarli, pungoli per la fisica contemporanea che si interroga su altre dimensioni e fertilizzanti per le fantasie acrobatiche di grandi scrittori, da Lewis Carroll a Franz Kafka (vedi Un messaggio dell’imperatore), da Italo Calvino a Jorge Luis Borges. E proprio come la biblioteca di Babele del racconto dello scrittore argentino, anche questo articolo che state leggendo non finirà mai, oppure, vi avevamo avvisato, voi non avete neanche iniziato a leggerlo.
Bibliocitazioni:
- Nicola Abbagnano
- Aristotele
- Jorge Luis Borges
- Clemente Alessandrino
- Italo Calvino
- Lewis Carroll
- Franz Kafka
- Friedrich Nietzsche
Cinecitazioni:
- Chistopher Nolan
- Robert Zemeckis
Telecitazioni:
- Tales from the Loop
Musicocitazioni:
- Philip Glass
Artecitazioni:
- Maurits Cornelis Escher